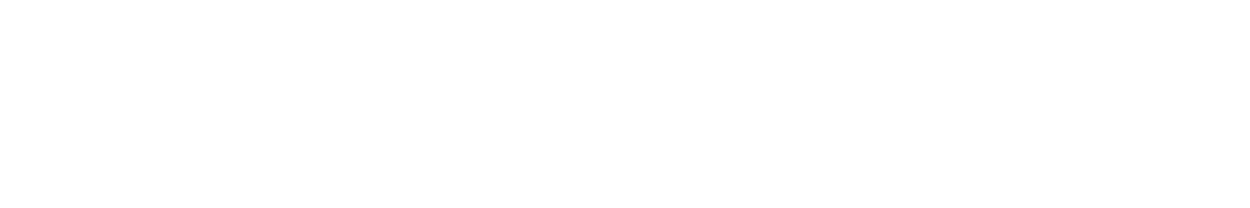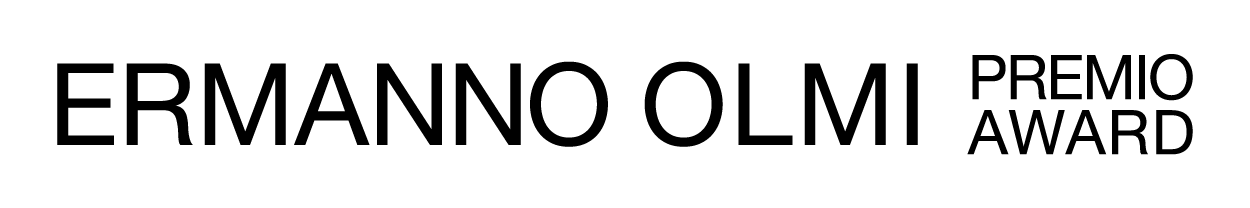È grazie a questa modernità che il cinema di Olmi, pur muovendo – e implicitamente rivendicando – l’assunto manzoniano di un esemplare protagonismo storico degli umili e dei vinti, lo sa poi capovolgere e rimettere con i piedi per terra, annullandone ogni aspetto paternalisticamente autoritario.
Non è certo facile scrivere di Ermanno Olmi nella fretta di pubblicare non tanto un ricordo quanto un sintetico percorso critico (fra i tanti possibili) attraverso l’opera che questo cineasta ci lascia in eredità e la cui complessità richiederebbe ben altri spazi e tempi per essere anche soltanto tratteggiata. Ci limiteremo dunque a qualche appunto/suggestione.
Vorremmo iniziare dal 1968: per Olmi l’anno del ritorno alla regia, dopo il “passo falso” di E venne un uomo, compiuto tre anni prima e dovuto soprattutto, come lui stesso ammise, all’incongruenza tra la radicalità del progetto e la scarsa determinazione nel portarlo compiutamente a termine. Il nuovo film, in quell’anno di rumore e furore, è Un certo giorno. In apparenza fuori asse rispetto a quanto succede tutt’intorno, come un’inquadratura sbagliata, affronta in realtà di petto il pensiero dominante del successo, del lavoro esercitato unicamente come fonte di profitto, della ricerca alienante di ricchezza e potere, scardinandolo dall’interno e mettendone a nudo l’intima fragilità, l’inconsistenza di fronte all’imprevisto.
Questo film sommesso, quasi nascosto nell’eccitazione generale in cui si consuma quell’anno cruciale con il quale è invece profondamente in sintonia, è il primo di una serie (verranno poi I recuperanti, Durante l’estate, La circostanza) che corrisponde al periodo meno esposto del suo cinema, dopo i consensi che ne avevano accompagnato l’esordio nel lungometraggio di finzione con Il tempo si è fermato (1959) e soprattutto Il posto, del 1961, mentre il successivo e straordinario I fidanzati (1963) aveva dovuto scontare un approccio narrativamente troppo sperimentale (ricevendo però, non a caso, l’apprezzamento di Godard). Periodo che si concluderà con la Palma d’oro attribuita a L’albero degli zoccoli nel 1978 e il conseguente ingresso a pieno titolo del regista nel novero dei grandi autori riconosciuti del nostro cinema.
Il tema del lavoro, che Un certo giorno mette alle strette nella sua componente più disumana, è in realtà al centro dell’interesse di Olmi fin dagli esordi documentaristici tesi a mostrare il contributo di operai e tecnici della Edisonvolta alla ricostruzione dell’Italia del dopoguerra e alla messa a punto di quella rete energetica indispensabile non solo alla nuova economia del Paese ma anche alla nuova qualità della vita dei singoli cittadini. Il lavoro è per Olmi il fare, l’agire che permette al soggetto di realizzarsi nella sua dimensione individuale e collettiva, che gli dà consistenza etica quando è esercitato nella consapevolezza dei riferimenti morali portanti, ma che conduce all’alienazione e alla perdita (di sé, del significato del proprio essere al mondo) quando quei riferimenti siano dimenticati. In questa idea del fare sta la continua e problematica ricerca del Bene: il cattolicesimo profondo di Ermanno Olmi va visto senza incertezze nella convinzione – dichiarata con la realizzazione di Il villaggio di cartone (2011) ma che è trasversale a tutta la sua filmografia, sostanziandone la poetica – che il Bene donato al prossimo sia superiore alla stessa Fede.
Le radici di questo pensiero si nutrono nel terreno fertile e difficile insieme del passato contadino e operaio, in cui Olmi si riconosceva senza per questo cessare di considerare il presente, le sue ambiguità, il suo stato di perenne crisi, con uno sguardo attento, acuto ma contemporaneamente sostenuto dalla serenità che gli derivava da una visione sostanzialmente positiva della condizione umana. Una serenità che gli permetteva di vedere la morte stessa come una «esplosione di significati da essere paragonabile al big bang che ha dato origine alla vita (…) l’ultimo istante può avere il valore di tutta la vita vissuta e di quella che non hai vissuto».
Il passato e il presente, grazie a questa inesausta fiducia che gli permetteva di cogliere la possibilità di fare il Bene in tutte le circostanze dell’esistenza, confluiscono nella modernità di un cinema che non ha mai esitato a misurarsi con differenti ambienti sociali, età d’uomo, epoche storiche; un cinema sempre in grado di coniugare l’altezza delle sue enunciazioni alla semplicità di cui sentiva il bisogno assoluto perché quelle potessero generare frutti. Senza sottrarsi a provocazioni “apocalittiche”: «Tutti i libri del mondo non valgono un caffè con un amico»; e senza sottovalutare la possibilità dell’epifania come dono riservato magari proprio a chi sembra costituzionalmente negato alla dimensione fattiva dell’operare per il Bene, come ci mostra La leggenda del santo bevitore.
È grazie a questa modernità che il cinema di Olmi, pur muovendo – e implicitamente rivendicando – l’assunto manzoniano di un esemplare protagonismo storico degli umili e dei vinti, lo sa poi capovolgere e rimettere con i piedi per terra, annullandone ogni aspetto paternalisticamente autoritario. I suoi film interpellano lo spettatore, gli rivolgono domande; anche quando danno risposte, queste non hanno mai la pretesa di essere esaustive, ma lasciano volutamente un margine alla continuazione del dialogo tra l’opera e il suo fruitore. Un cinema religioso, indubbiamente, ma nel significato più intenso e letterale che questo aggettivo può offrire: cinema che cerca la possibilità di un legame sempre nuovo tra gli esseri (tra i soggetti umani e tra questi e il mondo), prescindendo volutamente da ogni dogma e da ogni credo.
di Adriano Piccardi, direttore di Cineforum